Parlare di spazzatura: Tradurre la spazzatura
Un articolo di Cecilia Di Pierro
SALVIAMO L’AMBIENTE
GREEN TRANSLATION
TRADURRE SPAZZATURA O PRODURRE CAPOLAVORI?
Quando si parla di traduzione in questi giorni, spesso lo si fa con toni altissimi, come se si trattasse di un dovere sacro intrapreso da devoti adepti che si prostrano davanti all’altare della lingua. Si rinuncia a sè stessi, si rinuncia all’avidità dell’Autore per servire una vocazione più grande, che non è altro che quella di colmare i divari tra i popoli e le culture del mondo.
Questo è certamente vero se si traduce, ad esempio, Don Chisciotte, o opere di Autori strani, sconosciuti ai più. Ma solo una piccola minoranza di traduttori ha l’abilità, l’opportunità e la sicurezza finanziaria necessarie per intraprendere queste fatiche di Sisifo. Il resto di noi, per guadagnarsi da vivere, dovrà accontentarsi di tutta la “spazzatura”, rifiuti, per così dire, che riuscirà a procurarsi.
Per spazzatura intendo tutto o parte di ciò che segue: il linguaggio delle aziende, i manifesti dei marchi, i rapporti delle ONG, i rapporti dei think tank, grandi contenitori di vuoti pensieri, le lettere delle agenzie governative che rispondono alle compagnie petrolifere americane, le lettere delle agenzie governative che rispondono alle organizzazioni per i diritti umani, la prosa scritta da sedicenti prodigiosi i cui fondi fiduciari e la cui fiducia in se stessi pagano la traduzione, e il genere più sottovalutato di tutti, il testo artistico.
Non ho mai pensato di diventare un’Operatrice ecologica. È solo che, in quanto Traduttrice, avevo bisogno di una fonte di reddito effettiva per mantenere un tetto sulla testa, e doveva essere in linea con le mie competenze e gli studi effettuati.
Dopo aver lavorato come dipendente di una Casa farmaceutica, per sette anni, la crisi del settimo anno…
Decisione di lasciare l’Azienda per intraprendere la libera professione, iniziando la carriera da freelance quasi per caso.
Per un po’ ho pensato di aver trovato la formula magica, di aver trovato il lavoro secondario ideale per uno spirito libero e selvaggio come me.
L’idea sembrava ottima: puoi lavorare con il mezzo che ami, il tempo è tuo e puoi organizzarti come meglio credi (la mattina per scrivere, il pomeriggio per le traduzioni), il tragitto è lungo quanto il tempo necessario per andare dal letto alla scrivania, concedendoti qualche pausa per caffè; spuntini e intermezzi musicali, Singing and Dancing with the Boss, possono essere fatti tutte le volte che vuoi.
Cosa vuoi di più dalla vita? Una Lucana: eccomi!
Dall’entusiasmo iniziale mi accorgo che …
La Libera Professione comporta vantaggi e svantaggi: il vostro tempo è vostro solo in teoria. In realtà, ogni minuto appartiene al cliente. Il cliente il cui lavoro, perennemente super-urgente, deve essere portato a termine in un lasso di tempo che farebbe piangere Google Translate.
Il cliente che spesso si affretta a ricordarvi che, in questo mondo dominato da AI, essere multilingue non è una cosa speciale, e che ci sono orde di persone che aspettano dietro le quinte per svolgere il vostro stesso lavoro in meno tempo e per meno soldi.
Ecco che inizia l’estenuante corsa ai calcoli crudeli, cercando di valutare se questo lavoro, data la scadenza e il livello di difficoltà e/o di ricerca, necessario per familiarizzare con il gergo adatto, possa permetterci di comprare una piccola parte del nostro tempo da noi stessi, anche solo un paio di mattine a settimana, per mettere su una pagina alcune parole che non ci faranno venire voglia di strapparci i capelli in agonia (o almeno non nello stesso modo e per gli stessi motivi).
Adesso capite perché i miei capelli sono così ricci?
E, per aggiungere l’insulto esistenziale al danno materiale, quello che spesso si finisce per dover tradurre è una scrittura che ci fa odiare la scrittura, che non ha alcuna somiglianza con “il mezzo che amiamo”.
Amo il mio lavoro. Adoro tradurre.
Allora sei in contraddizione?
Tradurre o non tradurre? Il dubbio amletico
I dubbi sono fatti per portare certezze (Bischerate di Cecilia)
Domanda legittima, alla quale cercherò di rispondere in modo “garbato”, come sono solita dire, per fugare tutti i dubbi e convincervi del fatto che amo il mio lavoro alla follia.
Quando parlo di spazzatura, intendo mucchi di parole disposte in una sequenza che non segue alcun ordine sintattico o logico, buttate alla rinfusa in un contenitore e affidate a Traduttori senza scrupoli, che accettano qualsiasi lavoro pur di guadagnare, incuranti della specializzazione, della morale e delle regole che il Codice Deontologico impone. Mi riferisco alla selezione degli ingredienti che compongono la “zuppa” di pensieri non digeriti, che a volte vi lasciano così assuefatti da dimenticare le regole fondamentali della grammatica e da dover cercare su Google quali preposizioni vanno con quali parole.
Google Traslate o ChatGPT temono il flusso di pensieri di un Traduttore Umano.
LA SCELTA DI CECILIA
In ogni caso, le scelte che si devono fare con i testi terribili non sono meno delicate o complicate che con i migliori. Anzi, sono ancor più intrise di pericoli e tentazioni: la tentazione di cambiare ciò che si ha davanti per renderlo meno orribile; il pericolo di produrre qualcosa che sia meno una traduzione e più un ibrido, una collaborazione con qualcuno con cui si preferirebbe non essere in combutta. Per esempio, quando un ministero degli Interni risponde alle accuse di abusi sui detenuti e di coercizione violenta delle confessioni, è imperativo conservare fedelmente il doppio linguaggio. “Le nostre leggi proibiscono il maltrattamento” – qui si fa una distinzione dall’abuso più duro – ‘dei detenuti, e quindi è impossibile che ci stiamo impegnando in queste pratiche perché sono proibite dalla legge’. Potrei essere tentata di omettere la clausola finale, per quanto ripetitiva, eppure questa vuota insistenza è in realtà il nocciolo di ciò che viene espresso. A volte sono tentata di fare un editoriale, come quando un altro ministero ha risposto a un’organizzazione per i diritti umani: “Onorevoli Signori, forse siete consapevoli del fatto che negli ultimi tempi siamo stati devastati dalla guerra e dalle sanzioni, e quindi ci duole sottolineare che il Ministero ha giurisdizione solo di nome e che in realtà sono le milizie a essere responsabili della tortura dei profughi”. Mi immaginavo un burocrate esausto seduto in uno di quegli uffici spogli e piastrellati con le pareti scrostate, una scrivania di metallo e un antico computer da tavolo, una città in rovina intorno a lui, e volevo aggiungere, perché non lo faceva: “Sicuramente ha letto le notizie? Sicuramente, anche se ti sto scaricando la responsabilità, capisci l’inutilità di tutto questo sforzo da parte tua?”.
Questi testi sono sicuramente frustranti, ma sono più o meno diretti. Vedete, ogni traduttore di spazzatura finisce per avere la sua nicchia particolare, e la mia è un testo di medicina o legge. Si potrebbe dire che si tratta di letteratura, ma solo nel senso che la maggior parte di questi testi trasuda l’autocompiacimento della peggiore letteratura. Gli autori si danno delle arie, usano parole che non sembrano comprendere appieno, fanno nomi e cognomi in continuazione e cercano di gettare benzina sul fuoco a ogni piè sospinto, facendovi credere che la vostra incapacità di cogliere il loro punto di vista sia dovuta a una qualche mancanza da parte vostra e non da parte loro.
Niente mette in evidenza la vacuità di un testo d’Autore come il dover sviscerare ogni sua frase vuota. Una volta ho tradotto quasi trenta pagine di uno Studio Clinico e non sono riuscita a capire non solo di che patologia si trattasse, ma in che cosa consistesse lo Studio vero e proprio. Il testo era così astratto che aveva perso di vista la traduzione vera e propria. All’improvviso ero diventata io la Paziente: “Transfer traduttivo”.
L’esperienza di tradurre testi di questo tipo è descritta al meglio come un tentativo di trasporre delicatamente la patina impossibilmente sottile di una frase-nulla in qualcosa che si legga come una frase vera e propria, preservando al tempo stesso il vuoto scricchiolante attorno al quale è avvolta. Come raccogliere una pelle di serpente senza schiacciarla o piegarla. A prima vista, sembra un serpente, ne conserva l’anatomia: testa, squame e coda sono tutte al posto giusto e nell’ordine giusto. Ma è una cosa che crolla sotto il peso del minimo esame. Per esempio, ecco: “La maggior parte delle mie traduzioni ha superfici ondulate e rotolanti, nel tentativo di privare il materiale della sua trasparenza e di presentarlo in una forma visiva drammatica, una satira allettante che alla fine appare come un gran numero di superfici e forme ‘non coercitive’”. Sono quasi certa di aver chiuso gli occhi in un sonno riposante, dopo avere depositato le mie frasi sulla pagina. E in quei momenti, quando riesco a risolvere le cose, riesco quasi a convincermi che il testo, se non mi piace, almeno mi convince. Non è poi così male; devo solo capirlo nei suoi termini.
Ecco però che spuntano le metafore, quelle metafore di Troisi che tanto ci hanno fatto sorridere nei vari film del Grande Attore scomparso prematuramente. Metafore talmente varie da fare fatica a capirci qualcosa. Una volta mi è capitato di tradurre un testo di Thomas Mann, uno dei miei Autori preferiti, “I Buddenbrook – Storia e Decadenza di una famiglia” e di essere stata sopraffatta da un senso di inquietudine, rivoluzione dell’animo e agitazione.
Perché? Chiederete
Il mio modo di lavorare è questo: Per prima cosa metto sulla pagina la traduzione, per lo più grezza, stabilendo i parametri entro i quali posso muovermi. Lascio aperte solo alcune scelte, da fare/decidere/risolvere durante la lettura finale, per il desiderio, forse, di dare a me stessa un senso di controllo/gestione/illusione di essere più degna di Google in questo lavoro. Cerco di essere il più efficiente possibile durante questa fase, riducendo al minimo i brividi e il roteare degli occhi, cercando di non esaurirmi prima di dover davvero cogliere tutta l’essenza del testo davanti a me.
DUBBIO AMLETICO
Mi trovo costantemente in un dilemma morale: la mia responsabilità è verso la traduzione o verso la lingua stessa? Non si tratta di una preoccupazione del tutto altruistica, perché alla base c’è il timore che il lettore possa decidere che sono io il pessimo traduttore e non l’autore che è un pessimo scrittore. Per esempio, l’autore usa lo stesso verbo o lo stesso modificatore più volte all’interno di un singolo paragrafo, spesso in una singola frase. Il traduttore deve partire per una missione speciale per scoprire i sinonimi, oppure accettare semplicemente che il suo lavoro è tradurre le parole così come scoperte e abituarsi al fatto che se il suo autore non si è preso il tempo di aprire un maledetto thesaurus, allora, giocoforza, non lo farà nemmeno il suo Traduttore.
È successo più di una volta, tuttavia, che dopo aver inviato una traduzione, ho ricevuto un’email infelice da un autore che insisteva sul fatto che fosse imprecisa, che non fossi in grado di “penetrare appieno la poetica” del testo e che non avrebbe potuto scrivere ciò che io sostengo abbia scritto. Quando sono state presentate prove dettagliate a sostegno delle scelte fatte, più di uno ha ceduto ammettendo che in effetti l’inglese è una lingua arida e corporativa, incapace dell’intellettualismo giocoso del francese o della grandezza dell’arabo. Una scrittura terribile, vorrei rispondere, che in qualsiasi altra lingua si leggerebbe come “inquinata” “polluted”.
Se potessi fare questo lavoro in modo spassionato, non sarebbe così male. Ma di fronte all’audacia di una scrittura terribile ho la reazione di qualsiasi Professionista che difende a denti stretti la propria “Creatura”, la traduzione. “Come osano?”, penso, “Come osano”’, ma non oso finire il pensiero. “Come osano permettersi la libertà e l’autorità di scrivere, quando io mi sono trattenuta per tanti anni, producendo scritti a goccia a goccia, con il terrore di essere considerata carente o di risvegliare lo stesso disprezzo che provo quando leggo un testo scritto con i piedi e tradotto altrettanto male?
Ma questa rabbia è anche la traduzione più conveniente del senso di impotenza che questo lavoro spesso mi fa provare. Impotenza nei confronti del mio tempo, che non riesco mai a recuperare a sufficienza; impotenza nei confronti della mia situazione finanziaria, che rimane costantemente negativa, capelli rossi, tasche in rosso, e impotenza nei confronti dell’essere un ingranaggio di questa grande macchina economica alimentata da parole che fanno guadagnare un sacco di soldi a molte persone da qualche parte, ma che alla fine non danno alcun potere ai fautori della comprensione, i Traduttori. Tanti soldi versati a varie istituzioni, in contenitori di pensieri vari, per produrre rapporti antisettici, tutte quelle parole usate per gonfiare testi vari, cercando di dar loro una possibilità di competere nell’universo variegato di parole, dalle mille sfumature, “Le mille sfumature di un Traduttore”.
LA PERLA NERA
Quando parlo di spazzatura, intendo un puro spreco di parole, tanti rapporti, tante informazioni, tanto copy generato e poi riprodotto meccanicamente in un’altra lingua, solo, immagino, per rimanere ad ammuffire su qualche scrivania da qualche parte, o per essere accumulato informe in una galleria. La cosa migliore che posso dire a questo proposito è che il processo di traduzione è simile a un’affannosa ricerca della “perla nera”, quella rarità terminologica che farà della tua traduzione un capolavoro unico e di rara bellezza.
Alcuni scrittori, nel tentativo di convalidare un punto o due, inventano citazioni all’ingrosso e le attribuiscono a vari personaggi famosi, così che bisogna leggere interi saggi di autori specifici dopo aver passato ore a cercare traduzioni gratuite (in inglese, o altra lingua) per rendersi conto che, probabilmente, non abbiamo mai parlato di esilio o profughi su un’isola deserta. Che alcuni artisti, costretti a parlare una lingua che non comprendono appieno, spesso sminuiscono, travisano o sovraccaricano un lavoro che sarebbe stato meglio lasciare in piedi da solo e, viceversa, che altri lavori non hanno alcuna gamba su cui reggersi senza la stampella del discorso. Che, costretti a parlare la stessa lingua omogenea, gli artisti locali sono continuamente incoraggiati ad alzare il volume della propria “alterità”, qualunque essa sia, a gridarla dai tetti, come in tempi di pandemia, nella speranza di essere ascoltati da qualcuno, se non da tutti.
LO STILE FA LA DIFFERENZA
Ho certamente imparato a diffidare di qualsiasi opera che pretenda, in qualsiasi modo, di avere uno scopo morale. Questo scopo morale è per l’arte ciò che le uova sono per una torta. Se se ne sente il sapore o l’odore o se se ne vedono dei pezzetti scrostati infiltrarsi nel pan di spagna, allora si tratta di una torta fallita e mangiarla non è una delizia, ma un piatto indesiderato, dal gusto sgradevole.
REPETITA IUVANT (Semper e comunque: Ceciliata)
A prescindere dalla lingua tradotta, ciò che conta è lo stile di traduzione, il contenuto e la coerenza.
Analogamente, gli interventi apparentemente utili sono resi dissonanti dal rumore bianco della ripetizione di parole, o di idee, o di conclusioni. Cominciate a notare le tendenze e iniziate a vederle ovunque: nella cadenza di poesie e saggi, nelle voci di storie e romanzi, nel tenore dei nostri dibattiti, online e non, in quali storie, saggi, poesie e dibattiti siamo esposti e indirizzati a leggere. È difficile non pensare a come i nostri flussi di coscienza siano diretti dal flusso monetario (denaro, attenzione, capitale culturale); è più difficile resistere a farsi trascinare dalla corrente impetuosa e potente del fiume di parole, in piena.
TRADUZIONE – IL TUO STILE: LA TUA VOCE
Come faccio a sapere se sto parlando con la mia voce o se sto facendo da ventriloquo per la monocultura in generale? Perché voglio tradurre? In quale luogo arcano si cela questa ambizione? Chiedo, ma non ricevo risposte; rimangono solo le domande, e forse questo è importante. Forse è anche importante ricordare che uno dei mezzi per trovare uno scopo, trarre conforto o dare un senso a qualsiasi atto, a qualsiasi lavoro, è trovare un modo per farselo piacere. Nella mia scrittura, nella traduzione di testo altrui, questo si traduce nel piacere che nasce dall’inconoscibile, dall’affidarsi a domande che sono di per sé risposte. La cattiva scrittura intensifica il piacere che traggo dalla buona Traduzione. Ciò rende la buona traduzione più facile da riconoscere, perché posso continuare a perfezionare la mia definizione di ciò che non è. È un piacere modesto, semplice, privato. Soprattutto, soggettivo. Per questo adoro il mio lavoro. Il gusto della difficoltà in Traduzione: the HEAT, la SFIDA.
Per quanto riguarda il piacere che può derivare dal tradurre spazzatura, è, giustamente, di natura un po’ più trash. Un giorno, seduta davanti a un caffè con un amico, ho cercato di descrivere la sensazione di fare un lavoro che si ama in linea di principio, ma che spesso non si riesce ad amare sul momento. Di entrare in intimità con un testo per il quale non si prova altro che nausea, ma che comunque ti entra nella pelle, tanto che piccoli frammenti continuano a passarti per la testa per tutto il giorno, molto tempo dopo che te ne sei andato.
“Ti piace ciò che traduci”? Mi chiede qualcuno quando sa che lavoro faccio.
“Sì! Certamente! Non potrei mai tradurre ciò che non mi piace. Proprio come il pesce. Sono allergica al pesce, mi dà noia anche l’odore. Non potrebbe mai essere oggetto di traduzione”
IN CONCLUSIONE
TI PIACE TRADURRE? TUTTO, MA PROPRIO TUTTO?
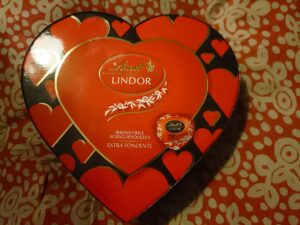 “E la cioccolata”?
“E la cioccolata”?
Che domanda!
Lindt. Un marchio una garanzia
Quale altro settore ti piace tradurre?
La musica.
Oh my Boss!
Traduzione è Musica
Musica & Parole
Parole in Musica
The Words that count
Le parole per dirlo
Ditelo in Traduzione
Gustatelo con un cioccolatino

